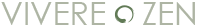Un attimo di vita che diventa verso
L’haiku ha origine in Giappone nel XVI secolo. Inizialmente indicato con il termine hokku (“strofa d’esordio”), deve il suo nome attuale allo scrittore giapponese Masaoka Shiki (1867-1902), il quale coniò il termine verso la fine del XIX secolo, quale forma contratta dell’espressione haikai no ku 俳諧の句 (letteralmente, “verso di un poema a carattere scherzoso”).
Il genere haiku, nonostante già noto e diffuso in Giappone, conobbe un fondamentale sviluppo tematico e formale nel periodo Edo, quando numerosi poeti tra cui Matsuo Bashō, Kobayashi Issa, Yosa Buson e, successivamente, lo stesso Masaoka Shiki utilizzarono prevalentemente questo genere letterario per descrivere la natura e gli accadimenti umani direttamente collegati ad essa. L’haiku, composizione di tre versi, rispettivamente di 5, 7, 5 more, ha origini molto incerte: sembra derivare dal genere di poesia classica giapponese chiamato waka 和歌 (letteralmente, “poesia giapponese”), poi ribattezzata tanka 短歌 (“poesia breve”) da Masaoka Shiki. Probabilmente nasce dalla ben più antica forma metrica che è quella del tanka (del quale assume ogni principio compositivo) che è poesia di 5 versi e di 5, 7, 5, 7, 7 sillabe, risalente al IV secolo nella sua forma originale di renga. Il renga era una poesia a due voci in cui un poeta componeva la prima strofa, haikai, di 17 sillabe in tre versi (5, 7, 5) mentre un secondo poeta doveva completarne il senso con una seconda strofa di 14 in due versi (7, 7). In questo competere, il primo poeta tendeva a rendere autonoma il più possibile la prima strofa, haikai, per mettere in difficoltà il secondo che ne doveva completare il senso. Dal renga derivarono, nelle epoche successive, il tanka ed infine l’haikai con il nome mutato in haiku.
L’ haiku per la sua immediatezza e apparente semplicità, fu per secoli una forma di poesia “popolare” trasversalmente diffusa tra tutte le classi sociali in contrasto alla ben più elaborata poesia cinese o alle costruzioni retoriche dei waka e solamente nel XVII secolo venne riconosciuto come una vera e propria forma d’arte grazie ad alcune opere di famosi scrittori tra cui Matsuo Bashō (1664/1694), che viaggiò in lungo e in largo nel suo paese tenendo un diario di viaggio dove annotava, molte volte in forma dihaiku, le proprie esperienze. Se anche non ne fu l’inventore, fu lui comunque a definire elementi specifici e caratterizzanti l’haiku, che sono diversi. Primo di tutti il kigo, la parola che definisce la stagione che fa da riferimento alla composizione ed attorno alla quale si dipana il contenuto e il significato dell’haiku stesso. Il kigo può essere esplicito, implicito oppure nascosto, riconoscibile solo dal poeta o dal destinatario della composizione. Altro elemento è la sua valenza autobiografica, in quanto, il poeta rende nella scrittura dell’haiku un’emozione personale, ovvero, il binomio compositore-composizione, in questa forma espressiva, non deve essere disgiunto; ciò fa dell’haiku un momento esistenziale del suo autore. Vi è poi spesso la voluta mancanza del soggetto e di collegamenti logici che rendono ancora più intimistica e criptica la composizione.
I versi dell’haiku sono strutturati in modo da presentare almeno un kireji 切れ字 (“parola che taglia”), ossia una cesura, un rovesciamento che può essere o meno indicato da un trattino, una virgola, un punto, ecc. Il kireji ha la funzione di segnalare al lettore un ribaltamento semantico o concettuale, un capovolgimento di significato che può avvenire ad esempio tra il primo e i due versi seguenti, oppure in qualsiasi altra posizione. La tradizione poetica risalente allo hokku, vuole, tuttavia, che tale stacco venga preferibilmente collocato al termine del primo o del secondo verso. Tale rovesciamento semantico è spesso indice della riuscita di un haiku, sottintendendo la complessità del sentire poetico e realizzando un salto dell’immaginazione tra concetti e immagini apparentemente distanti.
Questi i canoni classici da osservare, ma ricordando sempre l’invito dello stesso Basho: “Non seguire le orme degli antichi, ma quello che essi cercarono”. Lo haiku è una poesia dai toni semplici, senza alcun titolo, che elimina fronzoli lessicali e retorica, traendo la sua forza dalle suggestioni della natura nelle diverse stagioni. La composizione richiede una grande sintesi di pensiero e d’immagine in quanto il soggetto dell’haiku è spesso una scena rapida ed intensa che descrive la natura e ne cristallizza dei particolari nell’attimo presente. L’estrema concisione dei versi lascia spazio ad un vuoto ricco di suggestioni, come una traccia che sta al lettore completare. Significativa una frase di Basho: “A scrivere un haiku basta un ragazzino alto come un germoglio di bamboo”. Dobbiamo quindi ripulirci da tutte le strutture posticce che la società ci ha costruito attorno e riscoprire lo sguardo curioso del bambino che osserva i piccoli fatti del quotidiano con rinnovato stupore e ne coglie la bellezza. È forte in questi aspetti sia la matrice filosofica Zen sia quella naturalista, tipica giapponese, di derivazione animista shintoista. Nell’ haiku c’è il minimalismo Zen, il gusto della percezione di quei momenti unici e sfuggenti, di quei lampi di conoscenza e coscienza che sono parte della nostra esperienza e che si concretizzano in piccoli eventi solo apparentemente insignificanti.
“Chi si voglia cimentare nell’ascolto, con pazienza e tenacia, con vigilanza interiore ed attenzione, allontanandosi per qualche attimo dalla luce rutilante dei neon e dal frastuono dei miti quotidiani è destinato a giungere alle soglie della propria mente e poi a rientrare in quella danza cosmica dalla quale solo la disattenzione e la dispersione quotidiana l’avevano apparentemente esiliato.”( Pensiero Zen). In questo mescolarsi di filosofia Zen ed animismo Shintoista, nell’haiku, si concretizzano quattro stati fondamentali dell’animo umano: sabi, wabi, aware eyugen. Sabi: è la quiete, la pace, la solitudine, il distacco, la calma. Non c’è tristezza nè rimpianto, ma appagamento nella contemplazione che ci mette in completa comunione con l’oggetto contemplato. Wabi: l’inatteso, lo scuotersi, il riattivare l’attenzione, l’improvviso uscire da un momento di passivo grigiore nel quale nulla ha significato. Il riscuotersi dalla tristezza, dalla rassegnazione quando queste hanno il sopravvento e la malinconia ci assale. È allora che si realizza un piccolo evento che ci scuote e ci fa riscoprire nel poco il tanto e l’umile evento diventa illuminazione per il nostro cammino. Aware: il rimpianto, il ricordo, la nostalgia, la percezione della transitorietà di ciò che siamo, del mutare del tempo, della caducità, dell’inutilità dell’affanno. Non c’è sofferenza o senso di perdita, ma la consapevolezza del trascorrere del tempo e del divenire delle cose del mondo. Condizione che ci porta ad apprezzare le piccole cose di quotidiana semplicità, per la loro irripetibile unicità. Gli haiku racchiudono nella loro brevità momenti di illuminazione nei quali non c’è il soggetto, ma l’evento, è “come un attimo di vita che diventa verso. È una tessera di mosaico in cui il poeta[…] suggerisce immagini, sensazioni o emozioni.” (I. Iarocci “Cento Haiku”).
Tratto da digilander.libero.it